In questo periodo di quarantena, di distanziamento sociale e più in generale di mancanze e di distanze, in modo non previsto ma ben accetto, la lettura è riuscita a penetrare le mie difese, diventando risorsa preziosa e fondamentale, importante tanto quanto il pane, l'acqua, e le carezze.
Questo cambiamento non è stato radicale, nel senso che nel corso della mia vita ho sempre mantenuto una relazione - a momenti più sentita e vicina, a momenti più lontanta e distante - con la lettura. Detto questo, non penso di aver mai pensato alla lettura nel modo in cui ci sto pensando adesso. Come se la relazione con una vecchia e cara amica si fosse trasformata, in modo repentino, senza nessun tipo di avvertimento, e senza nessuna scelta in merito, in una profonda passione, di quelle passioni che ti fanno sentire talmente vivo da sfiorare la morte; di quelle passioni che, nel momento in cui le senti, sembrano interminabili.
Fin dalla mia infanzia ho sempre utilizzato la lettura come strumento di fuga, di evasione dalla realtà che mi circondava. Una realtà che fin troppo spesso, per qualche motivo, non riuscivo proprio ad accettare. Perché sono così? Perché mi sento così diverso dagli altri ragazzi della mia età? Perché sto bene solo quando sto da solo, solo quando non sento le pressioni delle altre persone, solo quando non mi sento giudicato? E perché mi sento sempre giudicato, per ogni parola e per ogni gesto? Riuscirò mai ad avere una genuina connessione umana? Queste sono solo una minuscola frazione delle domande che mi ponevo costantemente, ogni giorno, ad ogni incontro con la socialità. Ogni volta in cui toccavo il fondo, ogni volta in cui mi sentivo vuoto, cercavo qualcosa da leggere. Qualche storia fantasy, qualche romanzo. E non appena incominciavo a leggere, mi sentivo immediatamente meglio, più leggero, perché non ero più solo, perché le parole mi scaldavano.
Ripensandoci quindi, mi accorgo che la lettura è sempre stata lì, per me. La lettura mi ha sempre amato, aiutato e supportato. Anche quando non avevo nessun amico, anche quando ero completamente solo, chiuso in me stesso e senza vie di uscita. Ero io a non capire la sua importanza. Ero io ad essere ignorante ed ingenuo, a pensare che sì, mi piace leggere, ma ecco... è solo un piacere, un qualcosa che faccio ogni tanto per stare meglio. Ma appunto, ero ingenuo, e non solo del mondo, me anche e soprattutto di me stesso. Adesso, che mi conosco meglio, posso finalmente utilizzare le parole giuste per comunicare il mio rapporto con la lettura: pensa a quando sei talmente tanto assetato che il tuo mondo si riduce ad una bottiglia d'acqua; quando l'unica cosa a cui riesci a pensare è bere; quando faresti di tutto pur di toccare con le labbra anche la più piccola goccia d'acqua. Bene, per capire il bisogno che in questo momento provo per la lettura basta pensare a quanto appena descritto e sostituire la bottiglia d'acqua con un bel libro, e l'acqua con la conoscenza.
Una delle principali conseguenze di questa mia nuova passione si
riflette nelle particolari letture in cui mi cimento. Se un tempo
leggevo principalmente romanzi e storie fantasy, adesso sto
scoprendo per la prima volta un nuovo tipo di letteratura, una
letteratura che non sono mai riuscito ad apprezzare. Non saprei se
definirla letteratura d'autore, in quanto io, di lettetura, non ci
capisco molto. Preferisco piuttosto menzionare un nome, una persona
che, sorprendentemente, in questi mesi di difficoltà, mi sta dando
tantissimo: Primo Levi.
Alle superiori non ho mai letto nulla di Levi. Francamente ignoravo per la maggior parte la sua storia, e sapevo solo quello che tutti sanno di molte cose: poco e niente. Poi, questa estate, mentre aiutavo mio fratello minore a prepararsi per l'esame di stato, mi sono imbattuto in questo nome: Primo Levi, un chimico ebreo deportato ad Auschwitz durante la seconda guerra mondiale. Inizialmente fu una sorpresa per me scoprire che Primo Levi era un chimico: io lo avevo sempre e solo conosciuto come autore. Ero interessato. Ripensandoci credo che il suo essere chimico ha subito avuto un forte effetto su di me. Lo sentivo più vicino e più famigliare di quanto potesse mai essere un semplice scrittore, legato in qualche modo a me dalla bellezza di aver studiato, almeno in parte, la stessa matematica. Ma comunque, rimaneva per me un estraneo, e continuavo ad ignorare la sua storia. Dunque mi limitai ad ascoltare mio fratello ripetere e ripetere: lo aveva scelto come autore da portare per italiano.
Ora, non so esattamente come sia giunto a questa decisione, ma dopo
aver sentito mio fratello più volte ripetere una versione molto
semplificata della sua storia, e dopo aver discusso assieme alcune
frasi dette da Primo Levi, per cercare di capire ciò che intendesse
dire, ero troppo interessato dalla sua storia, e decisi di comprare
il suo primo libro, Se questo è un uomo. Era una scelta strana per
me, in quanto non avevo mai letto nulla del genere: storie reali. E
che storie: campi di concentramento, lo sterminio degli ebrei, la
seconda guerra mondiale. Storie reali di sofferenza reale. Tutto
ciò era tremendamente nuovo per me, e inizialmente non ero sicuro
se sarei riuscito a portare a termine la lettura. In ogni caso ero
troppo interessato oramai: l'acquisto, almeno, lo portai subito a
termine.
Per quanto inizialmente non sapevo se potesse essere un libro per me, una volta iniziato non mi sono più fermato, e dopo una sola settimana di una lettura lenta e goduta, mi sentivo strano, diverso, profondamente cambiato. Le parole di Levi mi hanno colpito, emotivamente e fisicamente. Non è stata una lettura facile, ma non è stata nemmeno una lettura difficile. È stata una lettura profonda e sentita. Una lettura che mi ha portato più e più volte alle lacrime. Una lettura che mi ha distrutto solo per poi farmi rinascere, spero più consapevole di prima. Sono stato talmente colpito da tale lettura che ho perfino voluto salvarmi alcuni paragrafi, che ho pubblicato in questo stesso sito nel post Se questo è un uomo. Ho voluto salvare e pubblicare quei paragrafi per due ragioni:
-
Per ricordarmi delle emozioni provate durante la lettura.
-
Per far conoscere Primo Levi. Per condividere il più possibile la sua testimonianza. Per aiutare a dare vita alle sue parole, che io ritengo essere di una bellezza unica e terrificante.
Finito Se questo è un uomo sentivo in me fin da subito la voglia di
saperne di più, la voglia di vedere nuovamente la realtà terribile
del mondo con lo sguardo di Primo Levi. Ma sapevo che avrei dovuto
aspettare, che dovevo assimilare per bene la potenza di questo
primo libro, e che solo in futuro sarei stato pronto per continuare
il suo viaggio.
Così, i mesi sono passati, e nel mentre ho continuato a leggere
altre cose. Ho letto anche un altro libro di Primo Levi, Il Sistema Periodico, che però non era il continuo di Se questo è un uomo ma
il cui tema centrale era raccontare la professione di
chimico. Anche questo libro mi ha dato molto, e sicuramente in
futuro vorrei scriverci su qualcosa. Comunque, dopo un po' di
tempo, qualche settimana fa, mi sono finalmente deciso di
continuare la storia di Primo Levi, comprando e leggendo il seguito
diretto al suo primo libro: La tregua.
In modo analogo a quanto fatto per il suo primo libro quindi, è mia
intenzione riportare i paragrafi che più mi hanno colpito del
continuo nel seguente blog post. Nuovamente, faccio questo con una
duplice intenzione: non dimenticarmi mai della bellezza
terrificante di queste parole, e condividere il più possibile
questo nome, questo libro, e tutto ciò che ne consegue. In termini
di paginazione, la versione del libro che ho comprato è la versione
SUPER ET. Segue una foto della copertina.
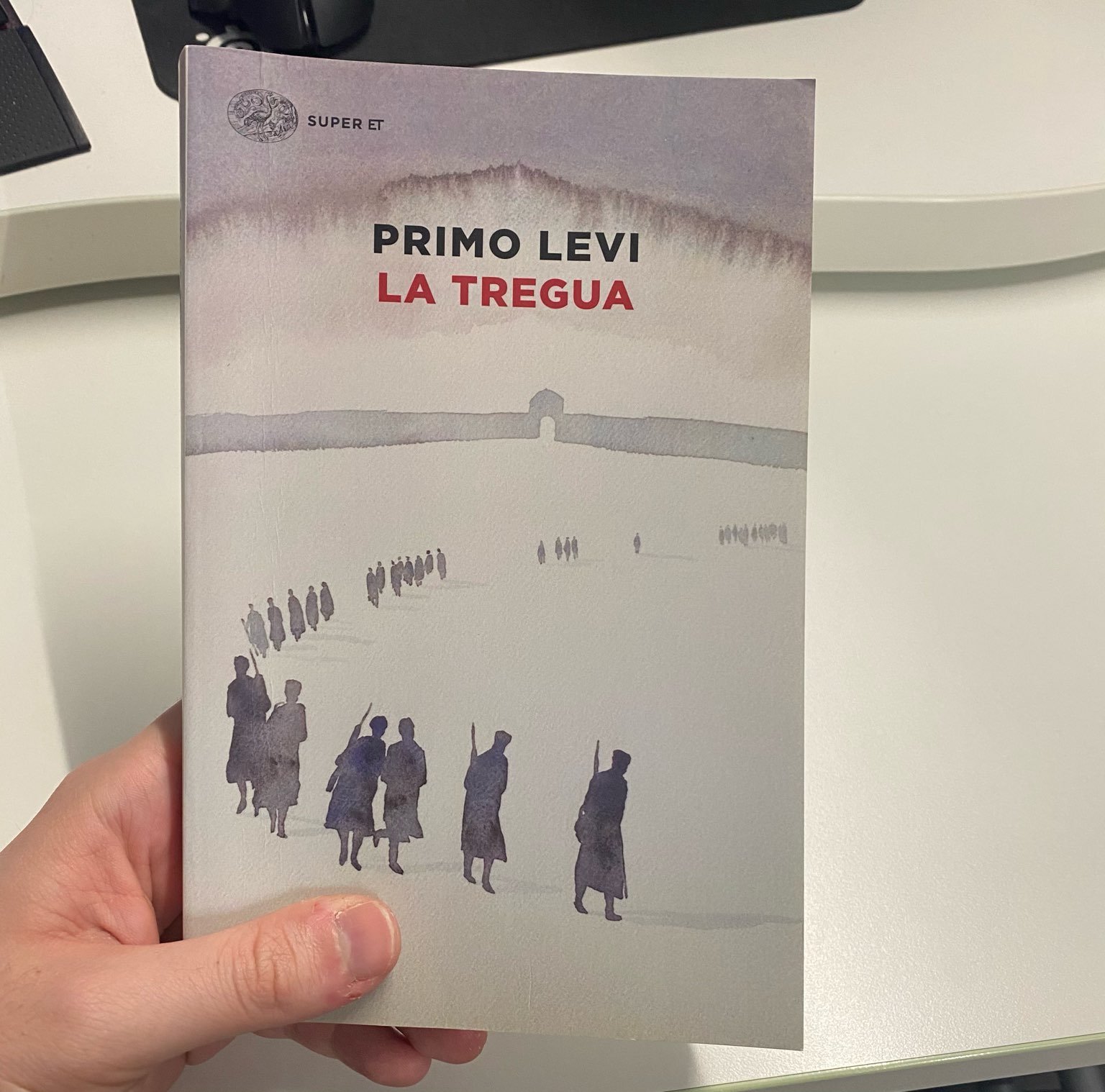
#L'armata Rossa
Mentre il suo primo libro, Se questo è un uomo, parla
dell'esperienza di Primo Levi nel campo di Buna-Monowitz, La tregua
inizia esattamente dalla fine del primo: nel momento in cui
l'impetuosa avanzata russa raggiunge il campo di
concentramento. Levi scrive:
Capitolo I, Il disgelo, pg 3.
Da vari indizi è lecito dedurre la originaria intenzione tedesca di lasciare nei campi di concentramento nessun uomo vivo; ma un violento attacco aereo notturno, e la rapidità dell'avanzata russa, indussero i tedeschi a mutare pensiero, e a prendere la fuga lasciando incompiuto il loro dovere e la loro opera.
Nell'infermeria del Lager di Buna-Monowitz eravamo rimasti in ottocento.
La prima pattuglia russa giunse il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles e io i primi a scorgerla.
In questo viaggio di ritorno l'Armata Rossa assume un ruolo critico, di fondamentale importanza, e più volte nel corso del libro è possibile ritrovare delle interessanti riflessioni di Levi in merito ai soldati russi. Come ad esempio quando parla della disciplina del tipico soldato russo.
Capitolo IV, Katowice, pg 49.
La guerra stava per finire, la lunghissima guerra che aveva devastato il loro paese; per loro era già finita. Era la grande tregua: poiché non era ancora cominciata l'altra dura stagione che doveva seguire, né ancora era stato pronunciato il nome nefasto della guerra fredda.
Erano allegri, tristi e stanchi, e si compiacevano del cibo e del vino, come i compagni di Ulisse dopo tirate in secco le navi.
E tuttavia, sotto le apparenze sciatte ed anarchiche, era agevole ravvisare in loro, in ciascuno di quei visi rudi e aperti, i buoni soldati dell'Armata Rossa, gli uomini valenti della Russia vecchia e nuova, miti in pace e atroci in guerra, forti di una disciplina interiore nata dalla concordia, dall'amore reciproco e dall'amore della patria; una disciplina più forte, appunto perché interiore, della disciplina meccanica e servile dei tedeschi.
Era agevole intendere, vivendo tra loro, perché quella, e non questa, avesse da ultimo prevalso.
O quando, l'8 maggio, viene annunciata la fine dell'interminabile conflitto.
Capitolo VI, Victory Day, pg 77.
La notizia, per quanto attesa, esplose come un uragano: per otto giorni, il campo, la Kommandantur, Boguice, Katowice, l'intera Polonia e l'intera Armata Rossa si scatenarono in un parossismo di entusiasmo delirante.
L'Unione Sovietica è un gigantesco paese, e alberga nel suo cuore fermenti giganteschi: fra questi, una omerica capacità di gioia e di abbandono, una vitalità primordiale, un talento pagano, incontaminato, per le manifestazioni, le sagre, le baldorie corali.
Oppure quando, in due occasioni diverse, viene descritto il rapporto che i russi hanno con le classificazioni e le distinzioni.
Capitolo VIII, Verso sud, pg 109.
Ma i russi, a differenza dei tedeschi, non posseggono che in minima misura il talento per le distinzioni e per le classificazioni. Pochi giorni dopo eravamo tutti in viaggio verso il nord, verso una metà imprecisata, comunque verso un nuovo esilio.
Italiani-rumeni, italiani-italiani, tutti sugli stessi carri merci, tutti col cuore stretto, tutti in balia della indecifrabile burocrazia sovietica, oscura e gigantesca potenza, non malevola verso di noi, ma sospettosa, negligente, insipiente, contraddittoria, e negli effetti cieca come una forza della natura.
Capitolo XI, Vecchie Strade, pg 132.
Non vi era da parte Russa alcuna velleità di pressione ideologica, anzi, nessun tentativo di discriminazione fra noi.
La nostra comunità era troppo complicata: ex militari dell'ARMIR, ex partigiani, ex Häftlinge di Auschwitz, ex lavoratori della Todt, ex rei comuni e prostitute di San Vittore, comunisti o monarchici o fascisti che noi fossimo, nei nostri confronti vigeva da parte dei russi la più imparziale indifferenza.
Eravamo italiani, e tanto bastava: il resto era "vsjò ravnò", tutto uguale.
Ammetto che, per quanto dolorose sono le tematiche affrontate da Levi, in questa lettura, a differenza dalla prima, più volte mi è venuto da sorridere, se non proprio da ridere di gusto. Un chiaro esempio di cosa intendo? Bene, basti pensare ai seguenti due bizzari comportamenti russi:
-
Il primo avviene verso la fine del viaggio, quando Levi si trova a Starjye Doroghi ("Vecchie Strade"), e un compagno del campo si mette a vendere, illegalmente, della carne di cavallo ottenuta a seguito del ritorno a casa dell'esercito russo. Ad un certo punto i russi si accorgono di quello che sta succedendo e decidono di punire l'incriminato con una detenzione nella cella della città. Le cose però prendono una piega inaspettata.
Capitolo XII, Il bosco e la via, pg 148.
Non era una punizione molto severa: alla cella, per oscure ragioni, forse per burocratico atavismo di un tempo in cui i prigionieri dovevano essere stati a lungo in numero di tre, spettavano tre razioni alimentari al giorno.
Che i detenuti fossero nove, o uno, o nessuno, non importava: le razioni erano sempre tre.
Così il macellaio abusivo usci di cella allo scadere della pena, dopo dieci giorni di sovralimentazione, grasso come un maiale e pieno di gioia di vivere.
-
Il secondo invece è quando, sempre a Starjye Doroghi, così, dal nulla, i russi diedero un compenso monetario agli ospiti del campo.
Capitolo XIV, Teatro, pg 168.
La faccenda non fu mai capita bene: secondo la interpretazione più savia, è da ritenersi che, per almeno alcuni ufficiali sovietici, noi fossimo equiparati a prigionieri di guerra, e quindi ci aspettasse un compenso per le giornate di lavoro prestate.
Ma con qualche criterio queste giornate venissero computate (quasi nessuno di noi aveva mai lavorato per i russi, né a Staryje Doroghi né prima); perché si retribuissero anche i bambini; e principalmente, perché la cerimonia dovesse avvenire così tumultuosamente fra le due e le sei del mattino, tutto questo è destinato a rimanere oscuro.
#Insegnamenti
Per quanto i russi assumono un ruolo fondamentale nel ritorno a
casa, La Tregua è anche pieno di altre cose. In un paio di
continaia di pagine, questo libro offre una ricchezza difficile da
catturare con qualche paragrafo. Eppure, ci sono alcuni paragrafi
che chiedono di essere condivisi. Paragrafi impregnati di una
saggezza affilata, chiara e semplice. Una saggezza talmente ovvia
che molto spesso, proprio per la sua ovvietà, sfugge anche e
soprattuto alle menti più intelligenti e allenate.
Capitolo III, Il greco, pg 28.
Mi sentivo stremato, non solo corporalmente: come un atleta che abbia corso per ore, spendendo tutte le proprie risorse, quelle di natura prima, e poi quelle che si spremono, che si creano dal nulla nei momenti di bisogno estremo; e che arrivi alla meta; e che nell'atto in cui si abbandona esausto al suolo, venga rimesso brutalmente in piedi, e costretto a ripartire di corsa, al buio, verso un altro traguardo non si sa quanto lontano.
Meditavo pensieri amari: che la natura concede raramente indennizzi, e così il consorzio umano, in quanto è timido e tardo nello scostarsi dai grossi schemi della natura; e quale conquista rappresenti, nella storia del pensiero umano, il giungere a vedere nella natura non più un modello da seguire, ma un blocco informe da scolpire, o un nemico a cui opporsi.
Un personaggio dalle poche ma preziose parole è Nordo Nahum, il
greco, a cui è dedicato un capitolo intero. Sono due le lezioni
che ho potuto imparare da lui. La prima è molto pratica:
l'importanza di avere un bel paio di scarpe ai piedi.
Capitolo III, Il greco, pg 31.
Ci eravamo ingannati grossolanamente sulla distanza da Cracovia: avremmo dovuto percorrere almeno sette chilometri. Dopo venti minuti di cammino, le mie scarpe erano andate: la suola di una si era staccata, e l'altra stava scucendosi. Il greco aveva conservato fino allora un silenzio pregnante: quando mi vide deporre il fardello, e sedere su di un paracarro per constatare il disastro, mi domandò:
- Quanti anni hai?
- Venticinque, - risposi.
- Qual è il tuo mestiere?
- Sono chimico.
- Allora sei uno sciocco, - mi disse tranquillamente. - Chi non ha scarpe è uno sciocco.
Era un grande greco. Poche volte nella mia vita, prima e dopo, mi sono sentito incombere sul capo una saggezza così concreta. C'era ben poco da replicare. La validità dell'argomento era palpabile, evidente: i due rottami informi ai miei piedi, e le due meraviglie lucenti ai suoi. Non c'era giustificazione. Non ero più uno schiavo: ma dopo i primi passi sulla via della libertà, eccomi seduto su un paracarro, coi piedi in mano, goffo e inutile come la locomotiva in avaria che da poco avevamo lasciata. Meritavo dunque la libertà? Il greco sembrava dubitarne.
La seconda lezione invece è più filosofica, direi quasi esistenziale: guerra è sempre.
Capitolo III, Il greco, pg 40.
Mi spiegò che essere senza scarpe è una colpa molto grave. Quando c'è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe, in secondo alla roba da mangiare; e non viceversa, come ritiene il volgo: perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale l'inverso.
Ma la guerra è finita - obiettai: e la pensavo finita, come molti in quei mesi di tregua, in un senso molto più universale di quanto si osi pensare oggi.
Guerra è sempre - rispose memorabilmente Mordo Nahum.
Altri insegnamenti invece derivano direttamente da Levi, quando ad esempio parla dell'importanza di non essere "qualunque".
Capitolo IV, Katowice, pg 52.
Fra le tante cose che avevo imparato ad Auschwitz, una delle più importanti era, che bisogna sempre evitare di essere "qualunque". Tutte le vie sono chiuse a chi appare inutile, tutte sono aperte a chi esercita una funzione, anche la più insulsa.
Perciò, dopo essermi consigliato con Leonardo, mi presentai a Marjia, e proposi i miei servizi come farmacista-poliglotta.
Ricordo in particolare quando, nel tempo passato a Staryje Doroghi, un giorno Levi decise di esplorare il bosco, finendo quasi col perdere la strada del ritorno (non ho inserito la storia per intero, ma, spoiler alert: sopravvive).
Capitolo XII, Il bosco e la via, pg 138.
La prima volta che vi penetrai, imparai a mie spese, con sorpresa e spavento, che il rischio di "perdersi nel bosco" non esiste solo nelle fiabe.
Avevo camminato per circa un'ora, orientandomi alla meglio col sole, visibile qua e là dove i rami erano meno fitti: ma poi il cielo si coprì minacciando pioggia, e quando volli tornare mi resi conto di avere perduto il nord.
Muschio sui tronchi? ce n'era da ogni lato.
Mi avviai nella direzione che più mi pareva giusta: ma dopo un lungo e penoso cammino fra i rovi e gli sterpi mi trovavo in un punto altrettanto indefinito quanto quello da cui mi ero mosso.
Alcuni insegnamenti fanno male, e fanno male proprio perché dicono la verità. Se dovessi riassumere questo libro con una frase, sarebbe la frase con cui Primo Levi termina il seguente paragrafo, scritto ripensando al momento in cui, dopo mesi di attesa, ebbero finalmente la notizia del loro imminente ritorno in Italia.
Capitolo XIV, Teatro, pg 170.
Uscimmo all'aperto in disordine, e fu dapprima un incrociarsi affannoso di domande senza risposta: ma poi vedemmo il colonnello, in mezzo a un cerchio di italiani, fare di sì col capo, e allora si capì che l'ora era venuta.
Accendemmo fuochi nel bosco, e nessuno dormì: passammo il resto della notte cantando e ballando, raccontandoci a vicenda le avventure passate, e ricordando i compagni perduti: poiché non è dato all'uomo di godere gioie incontaminate.
#Personaggi
La Tregua è anche piena di personaggi. Personaggi affascinanti,
ciascuno con il proprio passato, con il proprio modo di superare
le difficoltà, e, in particolare, con la propria moralità. Si può
capire molto di Levi semplicemente leggendo il modo in cui
descrive le persone e gli eventi: in poche, semplici parole, Levi
ti dice tutto quello che devi sapere.
Sono moltissimi i personaggi che compaiono nel viaggio di
ritorno. Qui ne menzionerò solo alcuni, iniziando con König, noto
come Henek, diminutivo polacco di Enrico.
Capitolo II, Il campo grande, pg 15.
Era stato catturato, e deportato ad Auschwitz con tutta la famiglia. Gli altri erano stati uccisi subito: lui aveva dichiarato alle SS di avere diciotto anni e di essere muratore, mentre ne aveva quattordici ed era studente.
Così era entrato a Birkenau: ma a Birkenau aveva invece insistito sulla sua vera età, era stato assegnato al Block dei bambini, ed essendo il più anziano e il più robusto era diventato il loro Kapo. I bambini erano a Birkenau come uccelli di passo: dopo pochi giorni, erano trasferiti al Block delle esperienze, o direttamente alle camere a gas. Henek aveva subito capito la situazione, e da buon Kapo si era "organizzato", aveva stabilito solide relazioni con un'influente Haftling ungherese, ed era rimasto fino alla liberazione.
Quando c'erano selezioni al Block dei bambini, era lui che sceglieva. Non provava rimorso? No: perché avrebbe dovuto? Esisteva forse un altro modo per sopravvivere?
Oppure Jadzia, una ragazza incontrata da Levi durante il suo
periodo di ricovero al Campo Grande (Auschwitz).
Capitolo II, Il campo grande, pg 19.
Jadzia era una ragazza piccola e timida, dal colorito roseo malato; ma il suo involucro di carne anemica era tormentato, lacerato dall'interno, sconvolto da una segreta continua tempesta.
Aveva voglia, bisogno, necessità impellente di un uomo, di un uomo qualsiasi, subito, di tutti gli uomini. Ogni maschio che passasse nel suo campo la attirava: la attirava materialmente, pesantemente, come la calamita attira il ferro.
Jadzia lo fissava con occhi incantati e attoniti, si alzava dal suo angolo, avanzava verso di lui con passo incerto da sonnambula, ne cercava il contatto; se l'uomo si allontanava, lo seguiva a distanza, in silenzio, per qualche metro, poi, con gli occhi bassi, ritornava alla sua inerzia; se l'uomo la attendeva, Jadzia lo avvolgeva, lo incorporava, ne prendeva possesso, con i movimenti ciechi, muti, tremuli, lenti, ma sicuri, che le amebe manifestano sotto il microscopio.
O anche, Rovi, incontrato da Levi nel suo periodo a Katowice
Capitolo IV, Katowice, pg 49.
Il ragionier Rovi era diventato un capocampo non per elezione dal basso, né per investitura russa, ma per autonomia: infatti, pur essendo un individuo di qualità intellettuali e morali piuttosto povere, possedeva in misura assai spiccata la virtù che, sotto ogni cielo, è la più necessaria per la conquista del potere, e cioè l'amore per il potere medesimo.
Rovi aveva conquistato la sua carica agendo con la stessa atavica spontaneità con cui il ragno costruisce la sua tela; poiché come il ragno senza tela, così Rovi senza carica non sapeva vivere.
Con chiaroveggenza sorprendente, che è come dire con un procedimento mentale altamente complesso e misterioso, aveva capito l'importanza, anzi la necessità, di possedere una uniforme, dal momento che doveva trattare con gente in uniforme.
Tra tutti, il personaggio che più mi ha fatto sorridere e che più
ricorderò con una sorta di affetto è stato sicuramente Cesare, a
cui Levi dedica un intero capitolo e molti paragrafi nel corso del
libro.
Capitolo V, Cesare, pg 69.
Cesare, benché avesse poco più di vent'anni, vantava una preparazione merceologica sorprendente, paragonabile a quella del greco. Ma, superate le analogie superficiali, mi resi conto ben presto che fra il greco e lui correva un abisso.
Cesare era pieno di calore umano, sempre, in tutte le ore della sua vita, e non solo fuori orario come Mordo Nahum. Per Cesare il "lavoro" era volta a volta una sgradevole necessità, o una divertente occasione di incontri, e non una gelida ossessione, né una luciferesca affermazione di se stesso.
Sono molte le storie che Levi ha potuto raccontare solo grazie alla presenza di Cesare. Non voglio rovinare la sorpresa raccontandole qui, in quanto penso che debbano essere godute all'interno del libro. Una di queste però la voglio solo introdurre, anche con l'intento di creare curiosità e interesse. La storia inizia nel seguente modo: Cesare e Levi si stanno spostando da Sluzk a Staryje Doroghi. Inizialmente stavano seguendo il resto del gruppo, ma ad un certo punto, assieme ad altri compagni italiani, decidono di accamparsi per la notte e riprendere l'indomani. A Cesare allora viene un'idea: mangiare una gallinella arrostita.
Capitolo X, Una curizetta, pg 122
Cesare è un uomo indomabile: già me n'ero potuto convincere girando con lui i mercati di Katowice.
Fu inutile rappresentargli che trovare un pollo di notte, in mezzo alle paludi del Pripet, senza sapere il russo e senza soldi per pagarlo, era un proposito insensato. Fu vano offrirli doppia razione di "kaša" purché stesse quieto.
- Voi statevene con la vostra cascetta: io la gallina me la vado a cercare da solo, ma poi non mi vedete più. Saluto voi e i russi e la baracca, e me ne vado, e torno in Italia da solo. Magari passando per il Giappone.
Fu allora che mi offrii di accompagnarlo. Non tanto per la gallina o per le minacce: ma voglio bene a Cesare, e mi piace vederlo al lavoro.
#La natura insanabile dell'offesa
Ma per quanto tematicamente questo nuovo capitolo della storia di Levi possa essere leggermente meno pesante del precedente, nessuno può tornare indietro oramai. Auschwitz è stata costruita, e noi tutti dobbiamo vivere con questa consapevolezza.
Capitolo I, Il disgelo, pg 5.
Poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno ha mai potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa, che dilaga come un contagio.
È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è una inesauribile fonte di male: spezza il corpo e l'anima dei sommersi, li spegne e li rende abietti; risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti, e pullula in mille modi, contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia.
Il danno che è stato fatto è terribile, distruttivo. Non possiamo
descriverlo in modo adeguato. Possiamo solo ricordare, ricordare
di quanto è stato. Non dimentichiamoci mai di Hurbinek, figlio
della morte, figlio di Auschwitz.
Capitolo II, Il campo grande, pg 13.
Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschiwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome: quel curioso nome, Hurbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva.
Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi; ma i suoi occhi, perso nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo.
La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnarli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con un urgenza esplosiva: era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena.
Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek, che aveva combattuto come un uomo, fino all'ultimo respiro, per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni di marzo 1945, libero ma non redento.
Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole.
Ricordiamo di Vanda, andata in gas, in piena coscienza.
Capitolo II, Il campo grande, pg 12.
E venne finalmente Olga, in una notte piena di silenzio, a portarmi la notizia funesta del campo di Birkenau, e del destino delle donne del mio trasporto.
Erano morti tutti. Tutti i bambini e tutti i vecchi, subito. Delle cinquececinquanta persone di cui avevo perso notizia all'ingresso del Lager, solo ventinove donne erano state ammesse al campo di Birkenau: di queste, cinque sole erano sopravvissute.
Vanda era andata in gas, in piena coscienza, nel mese di ottobre: lei stessa, Olga, le aveva procurato due pastiglie di sonnifero, ma non erano bastate.
#La tregua
La parte che più mi ha colpito del libro è stata sicuramente verso
la fine. Ricordo ancora infatti il paragrafo da me nominato Il
valore del tempo, ripreso da Se questo è un uomo. È stato quindi
un momento bellissimo leggere le seguenti parole
Capitolo XV, Da Staryje Doroghi a Iasi, pg 175.
Ci guardammo a vicenda, quasi smarriti. Avevamo resistito, dopo tutto: avevamo vinto.
Dopo l'anno di Lager, di pena e di pazienza; dopo l'ondata di morte seguita alla liberazione; dopo il gelo e la fame e il disprezzo e la fiera compagnia del greco; dopo le malattie e la miseria di Katowice; dopo i trasferimenti insensati, per cui ci eravamo sentiti dannati a gravitare in eterno attraverso gli spazi russi, come inutili astri spenti; dopo l'ozio e la nostalgia acerba di Staryje Doroghi, eravamo in risalita, dunque, in viaggio all'in su, in cammino verso casa.
Il tempo, dopo due anni di paralisi; aveva riacquistato vigore e valore, lavorava nuovamente per noi, e questo poneva fine al torpore della lunga estate, alla minaccia dell'inverno prossimo, e ci rendeva impazienti, avidi di gioia e di chilometri.
Ma il momento più emotivo è stato quando Levi e Leonardo, suo compagno di viaggio, si accorgono finalmente di essere arrivati in Italia. In questo momento, in cui sembrerebbe che il pericolo sia scampato, in cui si dovrebbero sentire al sicuro, entrambi sembrano già sapere che le cose non andranno così, e che il ritorno alla normalità avrebbe rappresentato una seconda guerra. Ma mentre la prima era stata combattuta nella realtà esteriore, con dei nemici visibili, la guerra che li avrebbe attesi sarebbe stata una guerra diversa, interiore. Una guerra invisibile ma fondamentale. Una guerra contro se stessi, contro il trauma subito dall'aver visto l'inferno ed essere sopravvissuti per raccontarlo. E dunque, è questa la vera essenza della tregua: il periodo di vagabondaggio ai margini della società; il periodo tra un conflitto - quello esteriore, dei campi di concentramento - e un altro conflitto - quello interiore, del ritorno alla normalità.
Capitolo XVII, Il risveglio, pg 199.
A notte fatta passammo il Brennero, che avevamo varcato verso l'esilio venti mesi prima: i compagni meno provati, in allegro tumulto; Leonardo ed io, in un silenzio gremito di memoria.
Di seicentocinquanta, quanti eravami partiti, ritornavamo in tre. E quanto avevamo perduto, in quei venti mesi? Che cosa avremmo ritrovato a casa? Quanto di noi stessi era stato eroso, spento? Ritornavamo più ricchi o più poveri, più forti o più vuoti?
Non lo sapevamo: ma sapevamo che sulle soglie delle nostre case, per il bene o per il male, ci attendeva una prova, e la anticipavamo con timore. Sentivamo fluirci per le vene, insieme col sangue estenuato, il veleno di Auschwitz: dove avremmo attinto la forza per riprendere a vivere, per abbettere le barriere, le siepi che crescono spontanee durante tutte le assenze, intorno ad ogni casa deserta, ad ogni covile vuoto?
Presto, domani stesso, avremmo dovuto dare battaglia, contro nemici ancora ignoti, dentro e fuori di noi: con quali armi, con quali energie, con quale volontà? Ci sentivamo vecchi di secoli, oppressi da un anno di ricordi feroci, svuotati e inermi.
I mesi or ora trascorsi, pur duri, di vagabondaggio ai margini della civilità, ci apparivano adesso come una tregua, una parentesi di illimitata disponibilità, un dono provvidenziale ma irripetibile del destino.
Volgendo questi pensieri, che ci vietavano il sonno, passammo la prima notte in italia, mentre il treno discendeva lentamente la val d'Adige deserta e buia. Il 17 di ottobre ci accolse il campo di Pescantina, presso Verona, e qui ci sciogliemmo, ognuno verso la sua sorte: ma solo alla sera del giorno seguente partì un treno in direzione di Torino.
Per finire, voglio includere questi ultimi paragrafi, che, come è solito di Levi, fanno intuire molto in poche parole.
Capitolo XVII, Il risveglio, pg 200.
Giunsi a Torino il 19 ottobre, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, che a sera cedette morbido soto il mio peso.
Ma solo dopo molti mesi svanì in me l'abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercavi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane; e non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento.
È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade e si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all'infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa: alzarsi, "Wstawać".